A parlarne alla quattordicesima Festa di Scienza e Filosofia sarà il professor Stefano Piccolo, con un focus sulla malattia e sull’avanzamento della ricerca oncologica. Appuntamento venerdì 11 aprile all’auditorium “San Domenico”
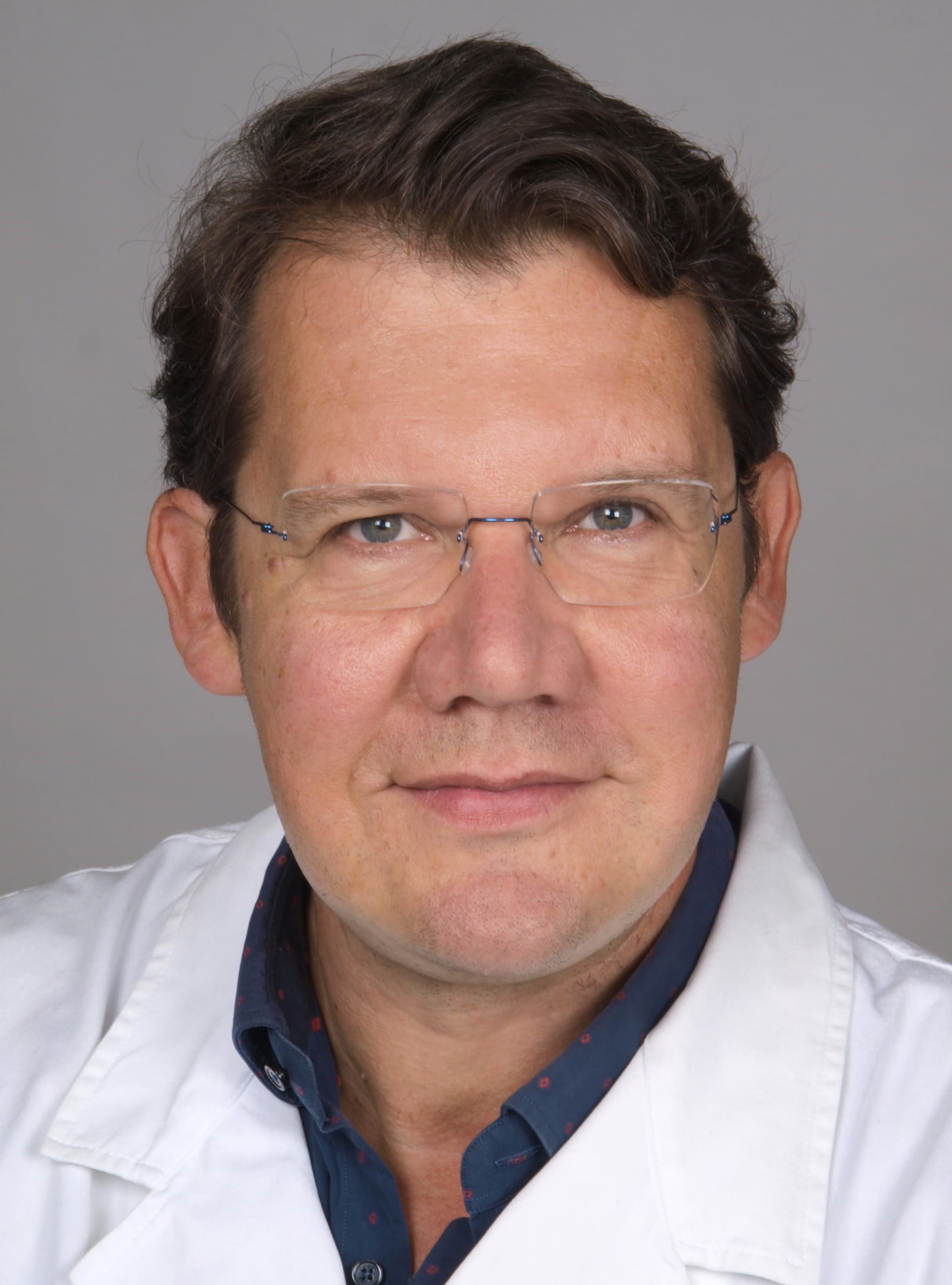
Prof. Stefano Piccolo
La malignità del cancro: genetica o ambiente? È l’interrogativo a cui, nell’edizione numero quattordici di “Festa di Scienza e Filosofia – Virtute e Canoscenza”, risponderà Stefano Piccolo, professore ordinario di Biologia molecolare alla Scuola di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Padova, che sarà all’auditorium “San Domenico” di Foligno venerdì 11 aprile alle 16.45.
Il professor Piccolo, che è direttore del Dipartimento di Medicina molecolare dell’ateneo veneto e anche ricercatore dell’Ifom-Airc di Milano, è a capo di un team di ricercatori e studiosi che attualmente sta studiando il microambiente che circonda le metastasi.
“La morte per cancro – spiega – è tipicamente causata non tanto dal tumore che noi definiamo primario, ovvero quello che si sviluppa nell’organo di origine, ma dal processo di malignità del cancro che definisce le metastasi. Ciò che uccide per cancro nel 90% dei casi è un processo complesso di disseminazione di cellule dotate di poteri speciali che emanano dal tumore primario e vanno a fare ‘casa’ in un organo distante, a loro del tutto alieno, e dove poi riescono anche a crescere. Quindi, ciò che è fondamentale oggi nella ricerca del cancro è, da un lato, attaccare il processo metastatico e, dall’altro, individuare i tumori che con maggiore probabilità saranno quelli metastatici”.
Ed è proprio quest’ultimo aspetto che è attualmente di difficile definizione.
“Prevedere se un tumore produrrà metastasi o no – prosegue – è oggi in molti casi un’impresa non fattibile. Definire il futuro, però, è fondamentale, perché permette di fare due cose: da un lato, evitare di sottoporre quei pazienti che sono portatori di tumori buoni o curati con chemioterapia ad un ‘overtreatment’ quando non ce ne sarebbe bisogno; dall’altro, di poter osservare con attenzione e di seguire con grande cura quelli che sono ad altissimo rischio. Riuscire a prevedere il futuro, quindi, è fondamentale”.
E, sebbene quando si fa riferimento al cancro, si parli soprattutto di genetica, c’è anche anche un altro aspetto da tenere in grande considerazione, quello legato, appunto, all’ambiente.
“Il cancro è una malattia originata da geni malati, che non funzionano come dovrebbero – sottolinea il professor Stefano Piccolo -, la malattia metastatica, invece, non è di carattere genetico. La genetica, infatti, non aiuta a distinguere le caratteristiche uniche delle cellule metastatiche, che hanno di fatto dei ‘superpoteri’. Ossia, la capacità di rimanere dormienti per molti anni e di essere camaleontiche, ovvero di evitare l’attacco da parte del sistema immunitario, quindi nascondendosi da esso e allo stesso tempo dirottando, a loro piacimento, il funzionamento di un normale organo in cui si trovano. Sono, dunque, cellule un po’ particolari, con delle caratteristiche uniche”.
Caratteristiche che, come spiegato dal professor Piccolo, non “sono dettate dalla genetica ma dall’ambiente in cui queste cellule si trovano”.
Ed è anche lì, dunque, che occorre andare a lavorare.
“Attraverso l’azione sull’ecosistema – dichiara – si può trasformare un tumore cattivo in buono. Esistono oggi farmaci innovativi e pazzeschi che lavorano nell’ecosistema, in quello che è la nicchia ecologica, il microambiente delle cellule, tra cui, ovviamente, i regolatori del sistema immunitario. Molti dei farmaci oggi in uso sono quelli che stimolano il sistema immunitario contro l’attacco”.
Un riferimento, dunque, all’immunoterapia.
“Noi – ha quindi sottolineato il professor Piccolo, introducendo il lavoro che sta portando avanti insieme al suo team – stiamo studiando il microambiente che circonda le metastasi e ciò che stiamo scoprendo è che proprio questo ambiente insegna alle cellule del tumore al seno a diventare particolarmente aggressive. Le stesse cellule aggressive del programma metastatico si trovano anche nei tumori primari ‘bad’, quelli cioè che vengono eliminati dal corpo del paziente grazie alle terapie o all’intervento chirurgico.
Il microambiente è composto da diversi elementi: cellule non tumorali che sono attratte dai tessuti sani circostanti, ma anche da strutture non cellulari, quella che di fatto si chiama matrice extracellulare, equiparabile ad esempio al sistema di cavi di cemento armato che sostengono una struttura. Questo ecosistema, dunque, ha una vera e propria architettura, segue le proprie geometrie, e le cellule sono letteralmente aggrappate a queste strutture. A certe geometrie di questa struttura corrispondono, quindi, delle geometrie cellulari e tessutali.
Rispetto a questo quadro, noi abbiamo scoperto che gli stimoli meccanici che arrivano dalla matrice exstrastrutturale hanno un ruolo fondamentale nel processo di metastatizzazione. In altre parole, noi lavoriamo sulla meccanica tumorale, siamo i meccanici della metastasi: la meccanica è proprio questo complesso sistema strutturale che tiene insieme il nodulo e noi sappiamo che il nodulo maligno, quello cioè che fa metastasi oltre alle metastasi stesse, ha una geometria ed una struttura davvero uniche ed è questo che ci permette di prevedere il futuro.
Quello che abbiamo scoperto è che questi stimoli meccanici sono intrinsecamente connessi al sistema immunitario, per cui l’architettura del cancro è cruciale per rendere il tumore immunologicamente freddo, e quindi invisibile e inattaccabile, piuttosto che caldo, ovvero visibile e distruttibile”.
Oltre all’aspetto strutturale, però, va considerato anche l’ecosistema “realizzato dalle altre cellule”, quello cioè non tumorali.
“Aspetto, questo – ha così aggiunto -, che si può studiare attraverso una tecnologia che si chiama trascrittomica spaziale, che studia appunto l’attività di geni, di migliaia di geni, lasciando intatta l’architettura. Oggi, quindi, è possibile guardare la mappa bidimensionale e tridimensionale del cancro, andando a vedere ogni singolo componente nella sua struttura, nella sua forma, nella sua disposizione spaziale; vedere, quindi, ogni singolo gene che è espresso in ogni singola cellula. Si tratta di dati colossali, se pensiamo che ci sono decine migliaia di geni in ogni cellula. E quindi, oggi è possibile andare a mappare e ordinare le cellule che rispondono a questo ecosistema buono e cattivo e capire quali sono i vantaggi, da un lato, dei buoni e quali sono, dunque, le istigazioni maligne dentro ai cattivi”.
